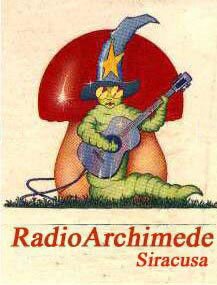
Milano, 12 dicembre 1969, mancano 13 giorni a Natale. E’ quasi sera ma Milano è illuminata a giorno. I grandi magazzini sono sfavillanti.
Le compere e gli acquisti. Le luminarie addobbano il centro che sembra un carnevale. Migliaia di persone stipate in pochi metri tra Corso Vittorio Emanuele,
Piazza Duomo e Piazza San Babila vanno su e giù, osservano le vetrine. Ci sono gli zampognari e i venditori di caldarroste, le vendite di beneficenza
e quelle private. Ai bar del Barba e Haiti servono espressi in continuazione, cinquanta lire a tazza. La gente transita nei pressi del Teatro alla Scala.
Quella sera rappresentano “Il barbiere di Siviglia”. C’è ressa davanti al Rivoli per “Un uomo da marciapiede” e all’Excelsior per “Nell’anno del signore”.
Il freddo entra nelle ossa, con il bavero alzato e i guanti presi da Crippa, e quel morbido pullover di cachemire comprato da Schettini, quella cravatta acquistata
poco prima da Avolio. Magari un cappello, un Barbisio, un Borsalino. I giovani stanno tutti in Galleria Passerella da Fiorucci per gli ultimi arrivi alla moda.
Quel viaggio verso Sud, con i biglietti acquistati in Stazione Centrale, si farà tra poco. Tutti noi italiani ci sentivamo felici, immortali, allegri, innocenti.
Ad un tratto, un forte e dirompente boato rompe quella strana ubriacatura invernale.
Alle 16,37, eravamo già vecchi, colpiti alla schiena, feriti nel nostro stesso orgoglio.
Sette chilogrammi d’esplosivo vengono compressi in una cassetta metallica, poi inseriti dentro ad una valigetta nera, tipo ventiquattro ore.
Collocata proprio al centro del salone dove gli agricoltori contrattano i loro affari. La gelignite verrà attivata da un timer. Un luogo strategico, un orario
scelto con cura, per fare uno scempio di vittime innocenti. L’attentato provoca la morte di diciassette persone, quattordici sul colpo, e ottantotto feriti.
Resta un grande, enorme foro nel mezzo della banca. Un profondo buco nero. Lì intorno sono ben visibili centinaia di piccoli frammenti metallici d’acciaio, quelli della cassetta dell’esplosivo. Un attentato tecnicamente perfetto. La resistenza opposta dal piano di cemento armato scaraventa l’onda d’urto contro
le pareti del salone. La potenza dell’ordigno si sviluppa tra il cemento e la parte sinistra del salone. Provoca il crollo del rivestimento sulla parete della banca.
Sono ore concitate ma non tutte le piste vengono seguite subito. Per diversi anni gli inquirenti, suggeriti dagli uomini dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero
dell’Interno, indirizzano le indagini v erso gli anarchici. Il ballerino anarchico pietro valpreda viene arrestato e accusato di aver organizzato la strage.
Viene fermato anche il ferroviere anarchico Pino Pinelli che cade dal quarto piano della questura di Milano durante un’interrogatorio.
Guido Lorenzon è il segretario di una sezione della Democrazia cristiana di Treviso.
La sera in cui Pino Pinelli vola dal quarto piano della Questura di Milano, Lorenzon si trova nello studio dell’avvocato Alberto Steccanella. Si morde le unghie,
è nervoso, teso, scuro in volto. Lui lo sa che quelle dichiarazioni potrebbero coinvolgere l’editore Giovanni Ventura che frequenta da anni. E’ a conoscenza
di fatti relativi agli attentati di Milano e Roma. Racconta che il 10 dicembre, ha parlato con Ventura. Informazioni precise e troppo circostanziate su quelle
bombe. Per Lorenzon, Giovanni Ventura sa troppe cose. Settimane prima del colloquio, Ventura gli descrive dieci attentati ai treni compiuti nel Nord Italia
nella notte tra l’8 e il 9 agosto 1969. Rivendica l’appartenenza a un’organizzazione clandestina. Parla di un progetto di colpo di stato imminente. Lorenzon
chiede consigli al suo avvocato, produce un memoriale alla magistratura e in pochi giorni si trova faccia a faccia al procuratore Pietro Calogero, I fatti narrati,
le conversazioni con Ventura diventano così oggetto di istruttoria. Lorenzon cerca Ventura, lo incontra più volte, i colloqui sono registrati dagli uomini
di polizia giudiziaria. In meno di un mese, Calogero raccoglie indizi e prove contro l’editore e il suo amico, Franco Freda.
La prima svolta dell’inchiesta avviene nel novembre del ’71.
Castelfranco Veneto. Un muratore sta riparando il tetto di una casa. E’ un professionista, uno di quelli di cui ci si può fidare
ma quel giorno commette però un errore. Sfonda il tramezzo divisorio di un’abitazione. Lì ci vive Giancarlo Marchesin, consigliere comunale socialista.
Il buco del tramezzo si allarga, i mattoni sono vecchi. Viene alla luce una santabarbara: armi ed esplosivi ovunque, tante, troppe casse di munizioni Nato.
Le manette scattano per Marchesin. Lui si defila, poi parla. “Le armi sono state nascoste da Giovanni Ventura, dopo gli attentati del 12 dicembre.
Prima si trovavano nell’abitazione di Ruggero Pan”.
La polizia interroga Ruggero Pan.
“Durante l’estate del 1969, dopo gli attentati ai treni, Ventura mi aveva chiesto di comprare delle casse metalliche tedesche di marca Jewell.
Quelle di legno usate per collocarvi gli esplosivi negli attentati, diceva Ventura, non avevano prodotto l’effetto sperato: quello di compressione esplosiva
del metallo. Mi sono rifiutato di acquistarle. Il giorno dopo, notai da Ventura una cassetta di metallo. Ho presto compreso che altri erano andati
a comprarla al posto mio”.
Pan dimentica ciò che è accaduto.
Ma il 13 dicembre 1969, il telegiornale mostra al paese la riproduzione di una delle cassette utilizzate negli attentati alle banche.
Nient’altro che una Jewell, proprio uguale a quelle acquistate da Franco Freda e Giovanni Ventura. Intanto c’è chi a Padova si ricorda di aver venduto delle
borse in pelle, identiche a quelle della strage. E’ Fausto Giurato titolare valigeria Al Duomo Padova. “ Ero in negozio. Stavo guardando giusto il telegiornale.
Mostrano la fotografia di una borsa. E una commessa dice: ’Signor Fausto, ma queste valigie le vendiamo anche noi. Il 10 dicembre ho fatto una vendita strana.
E’ entrato un giovanotto, gli ho fatto vedere la borsa, il prezzo gli andava bene. Gli gradiva il fatto che la borsa era capace, senza tramezzi e scomparti
ma ne voleva quattro. Io ci ho pensato diversi giorni, dopo gli attentati. Poi ho telefonato in Questura, ho chiesto del commissario, ho raccontato il fatto.
Non è successo niente. Dopo due anni circa, entra in negozio un carabiniere, mi mostra il tesserino. Mi fa vedere la fotografia delle valigie e io lo precedo
e gli dico: “Gli interessano quelle lì? Era ora che qualcuno mi chiedesse qualche particolare in più”.
I magistrati di Treviso si convincono che il gruppo si riunisce nella sala di un istituto universitario di Padova. Marco Pozzan, il custode, è il braccio destro
di Franco Freda. Viene interrogato. Spiega di quella riunione notturna a Padova il 18 aprile 1969 dove si sarebbe discusso del piano e degli attentati.
Prima accusa Pino Rauti di essere presente all’incontro. Alla fine ritratta.
Il sostituto procuratore Pietro Calogero non crede a Marco Pozzan. Quando è definitivamente in libertà, Pozzan fugge e scompare nel nulla. Racconta Pietro Calogero. “Gli apparati dello stato cominciano a lavorare non a favore delle indagini ma contro di esse. Non per collaborare con i giudici ma per intralciare e depistare il loro lavoro. Marco Pozzan, un uomo di fiducia di Franco Freda, colpito da mandato di cattura nel 1972 per concorso nella strage di Piazza Fontana. Pozzan aveva dato segni di cedimento in un interrogatorio e aveva rivelato fatti di notevole rilievo sulla strategia della tensione e sulla sua matrice di destra.
Era così importante avere la disponibilità fisica di Pozzan. E’ risultato dalle indagini che, verso la fine di quell’anno, uomini del Sid avevano intercettato Pozzan
durante la sua latitanza, lo avevano condotto a Roma, in via Sicilia, dove il Sid aveva gli uffici di copertura, lo avevano sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio, per saggiarne la tenuta e lo avevano fatto espatriare in Spagna con un passaporto falso”.
3 marzo 1972. E’ il giorno degli arresti di Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti. Ricorda ancora il magistrato Pietro Calogero. “Giovanni Ventura, colpito da mandato di cattura per complicità nella strage, dava segni di inquietudine e mostrava di voler fare rivelazioni sulla strategia della tensione.
Il Sid interviene non per collaborare. Attraverso un proprio emissario propone a Ventura un piano di fuga e gli mette a disposizione una chiave idonea
ad aprire le celle del carcere di Monza, dove è detenuto e due bombolette narcotizzanti per stordire gli agenti di custodia durante l’operazione”.
Il 21 marzo 1972, il giudice Giancarlo Stiz trasmette il fascicolo su Freda e Ventura, per competenza territoriale, alla procura della Repubblica di Milano.
Ora sono in tre a proseguire le indagini. In quel tempo lontano, sono i migliori investigatori di Milano, gente esperta. Sono il giudice Gerardo D’Ambrosio,
(attuale Procuratore della repubblica di Milano) e i sostituti Luigi Rocco Fiasconaro ed Emilio Alessandrini (ucciso anni dopo da un commando
di Prima Linea). Pino Rauti viene rilasciato. Giudici e magistrati milanesi raccolgono in poco tempo prove decisive contro il gruppo Freda-Ventura.
Dimostrano che la pista anarchica intrapresa all’inizio dagli inquirenti porta ad un vicolo cieco.
Tra il ’72 e il ’73 la magistratura milanese è dunque ad un passo dalla verità. Non solo le attività dei neofascisti veneti, emergono anche le coperture
dei servizi segreti, dei potenti apparati dello stato, dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno, di uomini in bilico tra i servizi e i neofascisti come
Guido Giannettini, sospettato di complicità nella strage. E puntuale scatta l’opera di depistaggio da parte dei servizi segreti. Ne è convinto Pietro Calogero.
“Giannettini subisce una perquisizione e verso la fine del 1972 è colpito da mandato di cattura. Il Sid interviene ancora una volta, non per collaborare,
ma per indurlo a sottrarsi alle investigazioni dell’autorità inquirente. Viene fatto espatriare in Francia dove sarà tenuto sotto controllo del servizio che,
invece di troncare ogni rapporto di collaborazione, continuerà addirittura a stipendiarlo”.
Nel 1973, la caccia agli attentatori di Piazza Fontana è in fase avanzata. Ora nelle mani del giudice D’Ambrosio, viene consegnato un appunto
del Sid del 16 dicembre 1969. Notizie di fonte qualificata, interna all’ambiente neofascista. “Gli attentati hanno certamente un certo collegamento con quelli
organizzati a Parigi nel 1968 e la mente e l’organizzatore di essi dovrebbe essere certo Y. Guerin Serac. Risiede a Lisbona dove dirige l’agenzia Ager- Interpress,
viaggia in aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera,è anarchico, ma a Lisbona non è nota la sua ideologia. Inoltre ha come aiutante Robert Leroy,
a Roma ha contatti con Stefano Delle Chiaie”. A parte alcuni errori, le informazioni risultano vere. E’ la pista intrapresa da Gerardo D’Ambrosio,
ben prima che la sua istruttoria venga fermata. Nel 1974, la Corte di Cassazione gli sottrae le indagini.
I risultati istruttori di Milano e di Roma vengono poi inviati a Catanzaro. Lì già convivono tre tronconi: quello romano orientato verso gli anarchici
(Valpreda, Merlino), quello milanese verso la destra (Freda e Ventura), quello calabrese (la strage di Stato con Gianettini, Gian Adelio Maletti del Sid).
L’unificazione avviene nel luglio 1976 con il rinvio a giudizio di trentatré imputati.
23 febbraio 1979, sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Catanzaro. Ergastolo per Freda, Ventura, Giannettini e Pozzan.
Due e quattro anni rispettivamente a Antonio La Bruna e Gian Adelio Maletti. Andreotti, Tanassi e Rumor rinviati a giudizio per reati ministeriali.
4 anni e 6 mesi di reclusione per Valpreda e Merlino, assolti invece dall’accusa di strage per insufficienza di prove.
20 marzo 1981. Corte d’Assise di Appello di Catanzaro. Assoluzioni per Giannettini, Freda e Ventura, per Maletti e La Bruna per il reato di falsità ideologica,
insufficienza di prove per Merlino. 15 anni a Freda e Ventura per associazione sovversiva. Proscioglimento per Pozzan.
10 giugno 1982. Corte di Cassazione. La sentenza di appello è annullata, il processo rinviato a Bari.
1 agosto 1985. La Corte di Assisi di Appello di Bari conferma le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove per strage
nei confronti di Valpreda, Merlino, Freda e Ventura. Riduce ulteriormente le pene contro La Bruna e Maletti.
Gennaio 1987. La Corte di Cassazione conferma la sentenza emanata dalla Corte di Assise di Appello di Bari.
Mentre il processo va avanti nel suo iter, prosegue la quarta istruttoria sulla strage di piazza Fontana. Dura dal 1981 al 1986.
Al centro delle inchieste ci sono Stefano Delle Chiaie e Massimiliano Fachini.
25 luglio 1989. Corte di Assise di Catanzaro. Assoluzione per Delle Chiaie e Fachini dall’imputazione del delitto di strage per non aver commesso il fatto.
5 luglio 1991. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro conferma la sentenza di primo grado. La sentenza di Appello diventa definitiva
per decorso del termine utile al ricorso per Cassazione.
Giunge il tempo della quinta istruttoria. Nel 1984, il giudice di Roma, Roberto Napoletano trasmette ai magistrati milanesi gli atti che riguardano le attività
eversive di Ordine Nuovo. Nel 1985, è in corso l’indagine sull’omicidio di Sergio Ramelli, giovane esponente del Fronte della Gioventù. La polizia giudiziaria
sequestra in viale Bligny, l’intero archivio di Avanguardia Operaia. Tra quei fogli, emerge un documento trasmesso da Renzo Rossellini al responsabile
del settore contro-informazione dell’organizzazione.
Il documento è di cinque pagine dattiloscritte. E’ un verbale di polizia giudiziaria in cui il neofascista Nico Azzi racconta tutte le attività del gruppo La Fenice
che fa capo a Giancarlo Rognoni. Nico Azzi, militante di Ordine Nuovo e del gruppo la Fenice è l’autore del fallito attentato al treno Torino- Roma del 7 aprile
1973. Lui mira alla strage ma il detonatore della bomba gli scoppia tra le gambe. Nel documento, Nico Azzi rivela cose non conosciute dagli inquirenti.
Il gruppo La Fenice di Milano è in contatto con Ordine Nuovo del Veneto. Dispone dei timer residuati dopo gli attentati del 12 dicembre 1969.
L’attentato sul treno Torino- Roma viene ideato per creare un diversivo rispetto alle piste investigative che portano alla destra veneta. Il gruppo La Fenice
è in stretto collegamento con ufficiali dell’Esercito, nel quadro della collaborazione tra militari e civili per l’effettuazione di un colpo di Stato.
Il 15 luglio 1988, il sostituto procuratore della Repubblica di Milano Maria Luisa Dameno formalizza l’istruttoria poco prima di passare ad altro ufficio.
Una settimana dopo, nel fascicolo, giungono anche gli atti dell’attentato contro il Comune di Milano del 30 luglio 1980.
I procedimenti passano ora nelle mani del giudice di Milano Guido Salvini.
721/88F. Inizia da questo numero di protocollo la nuova storia dell’inchiesta
per la strage di Piazza Fontana e le attività dei gruppi di Ordine Nuovo e La Fenice.
Dal 1988 al 1991, Salvini approfondisce la struttura logistica di Ordine Nuovo.
Nel ’91 nasce una collaborazione tra giudici e magistrati che tengono ancora aperte piste consistenti sulle attività della destra eversiva in Italia.
Non è un pool ma poco ci manca. Ci sono Leonardo Grassi di Bologna, Giampaolo Zorzi di Brescia, Giovanni Salvi di Roma,
Antonio Lombardi di Milano. Così il giudice Grassi trasmette a Salvini il procedimento 2/92F relativo a Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale,
definite “bande armate finalizzate a commettere stragi”.
Tra il ’91 e il ’92, Vincenzo Vinciguerra riprende il dialogo con la magistratura.
Riempie 150 pagine di verbali, fornisce testimonianze dirette e parla di La Fenice, dei contatti di questo gruppo con Ordine Nuovo del Veneto.
I primi elementi indiziari sulle stragi di piazza Fontana e di Piazza della Loggia a Brescia sono già in possesso degli inquirenti.
Vinciguerra svela così la struttura di Ordine Nuovo.
“Intendo fin d’ora affermare che tutte le stragi che hanno insanguinato l’Italia a partire dal 1969, appartengono ad un’unica matrice organizzativa.
Tale struttura obbedisce ad una logica secondo cui le direttive partono da Apparati inseriti nelle Istituzioni e per l’esattezza in una struttura parallela e segreta
del ministero dell’Interno più che dei Carabinieri. Posso oggi indicare i nominativi delle persone che dal 1960 o da ancora prima sono rimasti in collegamento
tra loro, provenendo da uno stesso ceppo ed essendo un gruppo politicamente ed umanamente omogeneo. Si tratta del gruppo che dette vita o aderì successivamente al Centro Studi Ordine Nuovo di Pino Rauti. Tale gruppo ha il suo baricentro nel Veneto, ma naturalmente ha agito anche a Roma e a Milano. E’ composto, fra gli altri da queste persone: a Trieste da Francesco Neami, Claudio Bressan e Manlio Portolan;a Venezia e Mestre da Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi e Giancarlo Vinello; a Verona da Marcello Soffiati e Amos Spiazzi; a Treviso da Roberto Raho; A Padova c’è l’intero gruppo di Franco Freda con Massimiliano Fachini e Aldo Trinco; a Trento è attivo Cristiano De Eccher; a Milano Giancarlo Rognoni; a Udine Cesare Turco dal 1973 in poi; a Roma Enzo Maria Dantini e il gruppo di Tivoli di Paolo Signorelli”.
1992. Il Sismi, il servizio segreto militare, individua nel suo rifugio all’estero Martino Siciliano. Tenta di farlo allontanare dai suoi camerati. Nel 1993 Carlo Digilio viene estradato da Santo Domingo. Collabora con la magistratura. Fatti e indizi sulla struttura associativa e sulle attività di Giancarlo Rognoni, Carlo Maria Maggi, Franco Freda e Giovanni Ventura. Fine del’93. Le testimonianze acquisite portano alla luce i Nuclei di Difesa dello Stato, struttura diversa da Gladio.
Nel 1994, Martino Siciliano si distacca dal sodalizio con gli ordinovisti che intendono trasferirlo in Giappone.
Accetta quindi la collaborazione, il rientro in Italia.
Contemporaneamente, le indagini su Piazza Fontana coinvolgono
Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi e Giancarlo Rognoni. Ricorda Martino Siciliano.
“Pochi giorni dopo la strage di Piazza Fontana, mi trovavo nella Galleria Matteotti di Mestre in compagnia di camerati del Msi, fra cui l’ex senatore
Piergiorgio Gradari. Parlando di quanto era avvenuto a Milano, ad un certo punto ebbi una crisi di pianto. Nel corso di questa crisi, confidai a Granari la mia
convinzione che la strage non fosse opera degli anarchici, ma che fosse da attribuirsi ad elementi di Ordine Nuovo di Venezia e Padova. Gradari mi consigliò
di calmarmi e mi disse che, anche se ciò che pensavo fosse stato vero, avrei dovuto tenermelo per me. C’era l’assoluta somiglianza fra gli ordigni che avevo
visto e materialmente deposto a Trieste e Gorizia con la descrizione che era stata fatta dai giornali della bomba esplosa alla Banca Nazionale dell’Agricoltura.
Intendo riferirmi al contenitore dell’esplosivo che era costituito in tutti e tre i casi da una cassetta metallica. I giornali, inoltre, avevano riportato la notizia
che l’esplosivo impiegato era costituito da candelotti di gelignite perfettamente analoghi a quello che avevo visto, manipolato e innescato insieme
a Delfo Zorzi nei due falliti attentati di Trieste e Gorizia. Mi è quindi venuta in mente l’affermazione di Delfo Zorzi nel corso del viaggio a Trieste.
Disse che vi erano molte altre cassette metalliche e molto altro materiale, cioè candelotti di gelignite come quelli che stavamo trasportando in quel momento”.
Anche la memoria di Carlo Digilio si apre ai dettagli.
“Delfo Zorzi mi chiamò per telefono dicendomi che aveva bisogno di una “consulenza”, espressione che io capii benissimo cosa voleva dire.
Arrivai a Piazza Barche, dove mi aveva dato l’appuntamento, nel tardo pomeriggio e Zorzi mi accompagnò in quella zona un po’ isolata vicino al canale
dove c’eravamo incontrati altre volte e dove in particolare avevamo esaminato il materiale proveniente da Vittorio Veneto. Mi portò in un punto molto riparato
dove era parcheggiata la Fiat1100 di Maggi. Qui aprì il portabagagli posteriore in cui c’erano tre cassette militari con scritte in inglese, due più piccole
e una un po’ più grande. Aprì tutte e tre le cassette e all’interno di ciascuna c’era dell’esplosivo alla rinfusa e in particolare quello a scaglie rosacee che avevo
visto nel deposito in località Paese e dei pezzi di esplosivo estratto dalle mine anticarro recuperate dai laghetti. In ogni cassetta, affondato nell’esplosivo c’era
una scatoletta metallica con un coperchio, come quelle che si usavano per il cacao, che conteneva il congegno innescante che era stato preparato, come lui
mi disse, da un elettricista. Effettivamente quello che vidi era una scatoletta di cartone a forma di parallelepipedo che nella parte superiore aveva una cupoletta
completamente avvolta con del nastro isolante lasciato un po’ molle e questa specie di cappellotto impediva di vedere come fosse fatto esattamente il congegno.
Zorzi mi disse di essere perfettamente sicuro di questo congegno, ma la cosa che lo preoccupava era la sicurezza generale dell’esplosivo che doveva trasportare
e cioè se poteva esplodere a seguito di scossoni, anche molto probabili in quanto la macchina di Maggi era vecchia. Mi disse che di lì a qualche giorno doveva
trasportare queste cassette fino a Milano e che comunque aveva previsto una fermata a Padova appunto per cambiare macchina e prenderne
una più molleggiata, oltre che per mettere a posto il congegno. Io lo rassicurai circa la sicurezza generale dell’esplosivo che non mostrava segni di essudazione
che ne alterassero la stabilità. Piuttosto avrebbe dovuto fare molta attenzione all’innesco che mi sembrava la parte più delicata”.
Strage di Piazza Fontana. Anni di inchieste, depistaggi da parte degli uomini degli apparati dello Stato, processi.
30 giugno 2001, Corte d’Assise di Milano.
I militanti del gruppo neofascista Ordine Nuovo, Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni, condannati all’ergastolo.
Tre anni a Stefano Tringali, per favoreggiamento nei confronti di Zorzi. Non luogo a procedere per il collaboratore di giustizia Carlo Digilio.
12 marzo 2004. La Corte d’Assise di Appello di Milano
assolve Delfo Zorzi e Carlo Maria Maggi per insufficienza di prove, Giancarlo Rognoni per non aver commesso il fatto,
e riduce da tre anni a uno la pena per Stefano Tringali con la sospensione condizionale e la non menzione della condanna.
3 maggio 2005, il processo si chiude in Cassazione con la conferma delle assoluzioni degli imputati
e l’obbligo, da parte dei parenti delle vittime, del pagamento delle spese processuali.
Oltre l’inganno, la beffa. I giudici compiono un vero capolavoro. Ma resta una verità storica anche dalle sentenze di assoluzione.
Le responsabilità di Franco Freda e Giovanni Ventura, ritenuti anche dalla Corte di Cassazione tra gli esecutori della strage di piazza Fontana,
anche se non più giudicabili dopo l’assoluzione definitiva nel gennaio del 1987.
Scrive il neofascista Vincenzo Vinciguerra, vi ricordate, reo confesso della strage a Peteano di Sagrato, in Friuli.
Scrive qualcosa che oggi possiamo solo sussurrare, ma non gridare ad alta voce.
Allora sussurriamo……..
“ Le stragi che hanno insanguinato l’Italia a partire dal 1969, appartengono ad un’unica matrice organizzativa.
Tale struttura obbedisce ad una logica secondo cui le direttive partono da Apparati inseriti nelle Istituzioni
e per l’esattezza in una struttura parallela e segreta del ministero dell’Interno.”.
Per questo ad oggi, per Piazza Fontana e per tutte le altre stragi, ancora nessuna giustizia.
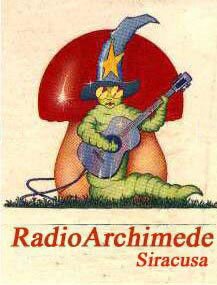 |